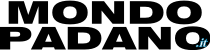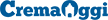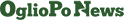Se uno Stato spende più di quanto incassa con la tassazione, incorre in un deficit di bilancio, che deve essere necessariamente finanziato. Ciò può avvenire in due modi: tramite l’indebitamento o l’emissione di moneta. Entrambe le modalità danno luogo ad un incremento del debito pubblico, che nel primo caso sarà fruttifero di interessi mentre nel secondo sarà espressione del signoraggio governativo. Questa possibilità, però, esiste solo quando la Banca centrale non è indipendente dal potere esecutivo, come accade ancora in generale per i Paesi in via di sviluppo; nei Paesi avanzati, invece, la Banca centrale è indipendente e decide autonomamente la propria politica monetaria, senza alcun vincolo statutario nei confronti dello Stato, per cui quest’ultimo deve coprire i propri deficit con il ricorso all’indebitamento, il cui servizio richiede il pagamento di un interesse e il rimborso del debito alla scadenza.
Nell’esaminare le problematiche connesse ai deficit e debiti pubblici, tuttavia, bisogna considerare non il loro livello assoluto, ma piuttosto il loro rapporto rispetto al prodotto interno lordo del Paese (Pil), per ovvi motivi di valutazione strutturale, e anche per consentire confronti internazionali. In effetti, le possibili conseguenze negative, connesse tanto ai deficit quanto ai debiti, nascono quando i loro rapporti rispetto al Pil sono elevati. In Europa, ad esempio, in seguito all’adozione del Trattato di Maastricht, si considerano particolarmente nocivi, e quindi meritevoli di considerazione e di intervento, rapporti tra deficit e Pil superiori al 3% e tra debito e PIL superiori al 60%. Più recentemente, nel 2012, il Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria, più comunemente noto come “Fiscal Compact”, ha addirittura stabilito che nei 25 Paesi dell’Ue firmatari il bilancio pubblico deve essere sostanzialmente in pareggio, al netto del ciclo, mentre l’eccedenza del rapporto tra deficit e Pil rispetto alla soglia di riferimento del 60% deve essere eliminata al ritmo di un ventesimo l’anno, con notevoli conseguenze sull’autonomia fiscale degli Stati.
Indipendentemente dai vincoli europei, è tuttavia evidente come un debito pubblico elevato e crescente sollevi problematicità che debbono essere necessariamente affrontate e risolte. Oltre a costituire un trasferimento di risorse dalle generazioni future a quella presente, se il rapporto tra debito pubblico e Pil continua a crescere si generano condizioni di insostenibilità, in quanto prima o poi i creditori non saranno più disposti ad assorbire ulteriori titoli pubblici nei loro portafogli, portando così o alla monetizzazione del debito o all’imposizione patrimoniale o al fallimento dello Stato. Si tratta in ogni caso di situazioni che avrebbero gravissime conseguenze sull’economia, in termini di iperinflazione, distruzione di ricchezza, crollo di reddito, produzione e occupazione, chiusura del sistema ai mercati finanziari internazionali. Nel breve periodo, inoltre, come la recente esperienza europea dimostra chiaramente, debiti pubblici elevati e crescenti in rapporto al Pil generano problemi di instabilità finanziaria, con repentini movimenti di capitale in uscita, innalzamenti dei tassi di interesse e difficoltà di reperire finanziamenti. Ciò induce i Governi ad adottare misure forzate di risanamento del bilancio pubblico, che hanno effetti disastrosi sulla crescita, innescando peraltro un circolo vizioso di rigore fiscale e recessione, dal quale risulta difficile uscire, tanto più quanto le misure di austerità vengono adottate simultaneamente da più Paesi in difficoltà.
Poiché dinamiche crescenti del rapporto tra debito pubblico e reddito determinano conseguenze negative assai gravi, ne consegue che in ogni caso, indipendentemente dai vincoli europei, tale rapporto va quanto meno stabilizzato e ricondotto ad un valore accettabile. In Italia, peraltro, da un punto di vista storico, dall’Unità ad oggi, ci sono state molte occasioni in cui si è operato un rientro del debito pubblico che aveva superato il 100% del Pil. Un primo episodio si ebbe all’inizio del ‘900 grazie ad una forte accelerazione della crescita reale e anche dell’inflazione, un secondo tra il 1924 ed il 1926 per mezzo di inflazione, restrizione fiscale e operazioni di consolidamento del debito interno e di condono di quello estero, un terzo alla fine della seconda guerra mondiale in seguito ad un’inflazione pari in media al 100% per circa 4 anni, un quarto, incompiuto, tra il 1994 ed il 2007 grazie ad una consistente azione di risanamento fiscale. A partire dalla cosiddetta Grande Crisi, però, il rapporto debito pubblico/Pil del nostro Paese è di nuovo aumentato di oltre 30 punti, come conseguenza soprattutto della diminuzione del denominatore. Come già osservato in precedenza, infatti, le politiche di austerità adottate per rispettare i vincoli europei hanno finito per rendere ancora più acuta la crisi e peggiorare l’evoluzione del rapporto. Peraltro vale la pena di osservare che la spesa per interessi vincola notevolmente la politica fiscale italiana incidendo in misura pari al 5,2% del Pil, per cui, al netto di tali esborsi, il bilancio pubblico del nostro Paese sarebbe addirittura in attivo per il 2,2% del Pil.
Quali misure si potrebbero adottare per uscire da tale situazione e consentire alla politica fiscale di stimolare il deludente processo di crescita reale? Misure straordinarie quali il ripudio, il consolidamento o la monetizzazione, conseguente ad esempio ad un abbandono dell’euro e un ritorno alla lira sarebbero esiziali per il nostro Paese, con distruzioni di ricchezza inaccettabili e possibili disordini civili incontrollabili. Le operazioni di privatizzazioni e di dismissione del patrimonio pubblico possono essere utili, ma trovano un limite nella dimensione degli interventi che bisognerebbe effettuare per incidere davvero sulla dimensione del debito pubblico. Il proseguimento di una politica di rigore di bilancio e di riduzione della spesa pubblica, soprattutto improduttiva, rimane quindi inevitabile. Di certo, se l’Unione europea vuole continuare ad essere un progetto ideale di Comunità di popoli e non soltanto un’area commerciale e finanziaria integrata, con vincoli fiscali talora incomprensibili o desueti, allora occorre modificarne profondamente l’architettura istituzionale, consentendo non solo alla Bce di diventare una vera Banca centrale con poteri di stabilizzazione reale e magari di socializzazione di parte dei debiti sovrani, ma soprattutto predisponendo efficaci strumenti di politica fiscale comunitaria, quali un adeguato bilancio pubblico europeo, spese e trasferimenti comunitari anticiclici e infine la possibilità di effettuare deficit spending tramite l’emissione di eurobond.
© Riproduzione riservata
-
09/05/25 14:30Segue »
Scavi, polvere e meraviglia:
Nuovo appuntamento con la rubrica Musica! Accordi & Disaccordi
i Pink Floyd a Pompei -
25/04/25 16:50Segue »
Formazione ampia, laboratori utilissimi
Federico Tessoni, il diploma da perito agrario e l’Istituto Academy, si racconta: «Scelta ideale per specializzarsi, ma anche per chi intende riqualificarsi» -
05/05/25 18:25Segue »
Consegnata la borsa di studio intitolata ad Agostino Ottoli
Come da tradizione il 1° maggio, al Circolo “Carlo Signorini”, si è svolta la cerimonia di consegna della borsa di studio intitolata ... -
09/05/25 16:50Segue »
Protagoniste le idee dei giovani
Concluso il contest “L’Orientamento che vorrei. Tracce di futuro dalla voce degli studenti” -
30/01/25 22:30Segue »
Web e minori, quei pericoli da conoscere
Una guida pratica per i genitori e gli insegnanti ai rischi connessi all'uso di Internet e dei Social da parte dei giovani. In abbinata a Mondo Padano in edicola fino al 6 febbraio: tutto quello che c’è da sapere su social, dipendenza dalla rete, cyberbullismo, perdita di privacy.
IN ALLEGATO LA GUIDA COMPLETA "INTERNET E MINORI" -
09/05/25 10:15Segue »
Da Cremona alle stelle, il viaggio è breve
Stefano Boccelli, la maturità scientifica all’Aselli, la laurea in Ingegneria al Politecnico... la NASA. Lo sbarco negli Usa grazie allo studio di Giove. Oggi l’esplorazione della Luna
Accedi e sfoglia la tua copia online di Mondo Padano.
Non sei ancora abbonato? Clicca qui per conoscere tutte le offerte in abbonamento.
Registrati subito e acquista la tua copia digitale dell'assetto settimanale.